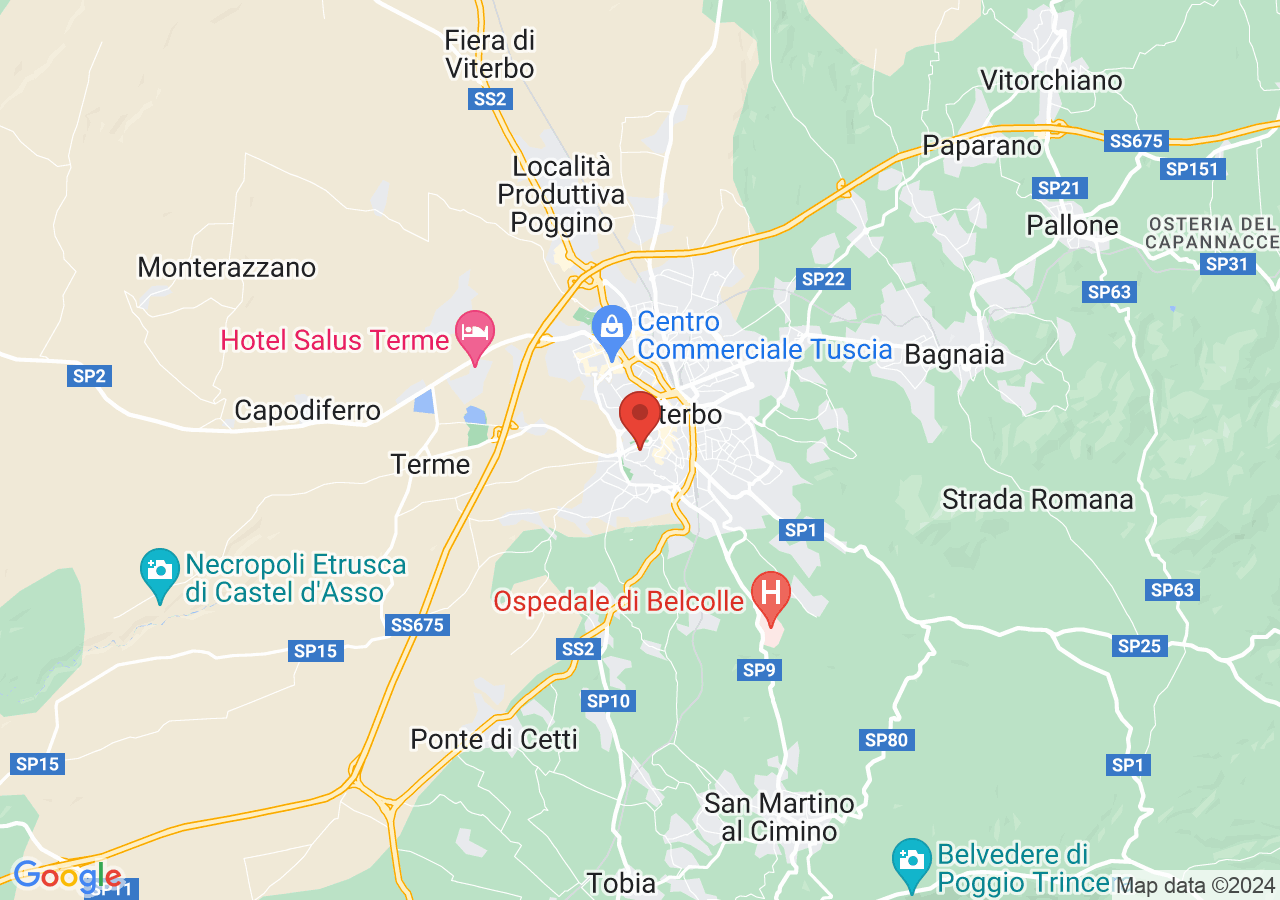Palazzo dei Papi di Viterbo. Il trasferimento della Curia pontificia nei primi anni della metà del XIII secolo comportò la necessità di adeguare il palazzo nel quale questa avrebbe preso posto. Storicamente, infatti, le crescenti opposizioni al papato che si registravano a Roma, spinsero il clero ad una decisione che permettesse di sottrarre la Chiesa ai dissidi con l’impero. Quando papa Alessandro IV spostò a Viterbo la stessa a causa degli attriti con la nobiltà romana, la struttura che conteneva la Curia vescovile dovette essere ampliata perché ivi potesse essere allocata quella pontificia. L’arco temporale di permanenza del papato a Viterbo si estese dal 1257 al 1281. Delle nuove ed accresciute dimensioni fa parte anche la sala del Conclave, ove venne tenuto il primo, durato oltre mille giorni a tra la fine del 1260 e l’inizio 1270. La durata è ad oggi rimasta ineguagliata, facendo del conclave il più lungo mai registrato, che servì ad appianare le forti contrapposizioni sorte in occasione della dipartita di Urbano IV.
Le splendide merlature rettangolari della facciata rendono il palazzo una visione monumentale e finemente organizzata, mentre la parte che affronta il precipizio laterale mostra contrafforti che accrescono l’imponenza dell’edificio. Al palazzo si accede tramite il portale che segue alla scalinata e che, dalla volta a tutto sesto, è sormontato dal simbolo di Viterbo, il leone, e dall’emblema di San Bernardino da Siena.
Architettura di spicco risulta senz’altro la loggia delle Benedizioni, dove i nove papi che nella costruzione principale risiedettero, si mostravano in uscita dalla sala del Conclave. Il loggiato è una pregevolezza architettonica dalle sette aperture a sesto acuto affiancate nella parte alta da quadretti recanti simbologia del paese e dall’aspetto gotico. Le arcate sono a forma ogivale e il colonnato che le sostiene è composto da elementi abbinati a coppie; dalla costruzione si gode una veduta incantevole sulla Tuscia laziale, che nelle stagioni fredde si veste di vibranti colori.